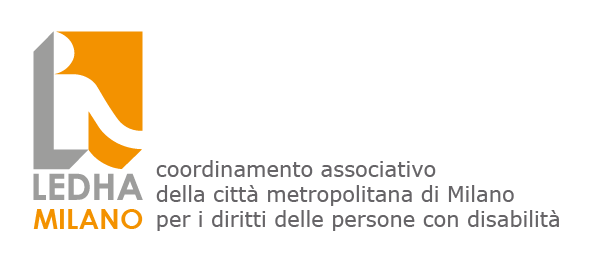I primi segnali che c’era qualcosa di strano li ho avuti durante il mese di gennaio: quando io, i miei quattro coinquilini e tutti gli operatori abbiamo avuto una strana influenza, sebbene tutti noi ci fossimo vaccinati in precedenza. Quando sono arrivate le prime notizie dalla Cina e quando è stata chiara la reale portata dell’epidemia di Coronavirus mi sono blindato in casa. Era il 7 marzo 2020. Come è successo in altre strutture residenziali, abbiamo concluso un accordo con i nostri operatori per fare in modo che restassero con noi per tutto il tempo necessario: la sera non tornavano a casa a dormire, ma trascorrevano la notte in un appartamento vicino al nostro, che ci è stato concesso gratuitamente. In questo modo abbiamo potuto ridurre in maniera significativa il rischio di un contagio.
Le difficoltà della “Fase uno”, quella del lockdown più rigido, sono state tante. Ad esempio, trovare le mascherine e i dispositivi di protezione individuale. Ma quello che più mi è pesato è stato dover interrompere tutte la attività che svolgevo prima: sia quelle lavorative sia quelle relative al tempo libero e le semplici relazioni interpersonali.
Da metà maggio, con l’inizio della cosiddetta “Fase due”, la maggior parte dei cittadini italiani ha progressivamente ripreso a svolgere le proprie attività quotidiane. Il lavoro in ufficio, gli spostamenti quotidiani per le commissioni, una visita a parenti e amici, una passeggiata al parco o semplicemente per le strade della propria città. Da giugno “persino” la possibilità di spostarsi fuori regione. Ma per me (come per tante persone che hanno delle fragilità di carattere respiratorio pre-esistenti) la convivenza con il virus è molto più problematica, quasi impossibile. E lo sarà fino a quando non verrà trovato un vaccino.
Il futuro riserverà molte sfide alle persone con disabilità, per questo è importante mantenere alta fin da ora l’attenzione e soprattutto “l’asticella” dei diritti.
Le grandi istituzioni -che siano per anziani o per persone con disabilità- hanno fatto il loro tempo e devono essere re-inventate. L’epidemia di Covid 19 ha messo in luce in maniera drammatica le criticità e i problemi di queste strutture: luoghi che si impegnano a “custodire” decine e a volte migliaia di persone. Ma che, spesso, non sono state in grado di farlo. Occorre quindi immaginare un modello nuovo. O meglio, mettere al centro della programmazione degli interventi un modello che pone al centro il progetto di vita individuale delle persone, che LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità propone da anni. Occorrono un maggiore coinvolgimento dei territori e una diversa gestione delle risorse del comparto sociale e socio-sanitario per dare a tutte le persone -con disabilità e anziane- la possibilità di scegliere dove e come vivere. Certo, ci sarà sempre l’esigenza di strutture specializzate, soprattutto per la presa in carico delle acuzie, ma l’obiettivo finale deve essere quello di far ritornare le persone sul territorio
La seconda sfida riguarda la fase di “convivenza con il virus”, che è particolarmente critica per le persone che già soffrono di più patologie o di particolari fragilità. Limitarsi a dire a queste persone che non devono uscire o che devono continuare a restare in condizione di isolamento come se si trovassero ancora nella “Fase uno” non può essere una risposta. Sono molte le sfide a cui occorre dare una risposta. Innanzitutto, le istituzioni devono intervenire con urgenza per alleviare le fatiche delle famiglie che in questi tre mesi hanno dovuto gestire in completa solitudine il carico del lavoro di cura dei propri familiari con disabilità. È importante che i centri diurni e i centri residenziali riprendano a lavorare, ma con uno spirito nuovo: mettendo al centro il progetto individuale di ogni persona che frequenta quello spazio. O, perché no, che sceglie di restare ancora a casa propria, ma non per questo rinuncia alle proprie aspettative e ai propri desideri.
Enrico Mantegazza,
presidente LEDHA Milano